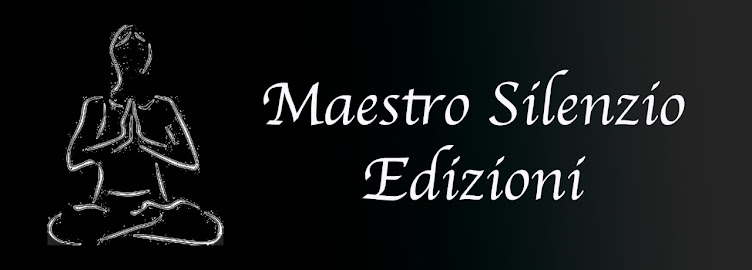Ipotesi su un modello avanzato introdotto nel modo sbagliato
Esistono idee che, più le si osserva da vicino, più rivelano una strana ambiguità. Il comunismo è una di queste.
Non come slogan politico, ma come riflessione storica e filosofica: assenza di competizione economica, centralità della cooperazione, superamento della proprietà privata come fine ultimo, distribuzione dei ruoli secondo capacità e necessità. Elementi che, presi singolarmente, appaiono tutt’altro che primitivi. Anzi, per certi versi, sembrano estremamente avanzati.
Eppure, storicamente, il comunismo è stato bocciato. Non ha prodotto libertà, ma appiattimento. Non ha liberato l’individuo, ma lo ha sacrificato. Non ha generato felicità, ma controllo.
La domanda allora non è solo perché ha fallito, ma cosa è fallito. Se è fallito davvero il modello o forse un sua versione incompleta?
Marx e il contesto: motivazioni storiche che stanno in piedi
Karl Marx non era un folle né un ideologo astratto. Le sue motivazioni storiche sono comprensibili e, per molti aspetti, legittime.
Egli osserva:
uno sfruttamento sistemico e disumano della classe operaia;
una religione istituzionale spesso alleata con il potere economico;
un uso della spiritualità come strumento di giustificazione dell’ingiustizia sociale.
Prima ancora di Marx, si era già prodotta un’associazione curiosa e potentissima: religione e capitalismo avevano stretto un’alleanza di fatto. La religione, privata progressivamente della sua funzione spirituale autentica, veniva utilizzata come apparato morale di contenimento, come promessa differita, come legittimazione del sacrificio terreno in favore di una ricompensa ultraterrena.
È qui che si può individuare una prima fase cruciale.
Se religione e capitalismo appaiono come alleati, allora il ragionamento di Marx diventa quasi inevitabile:
capitalismo = oppressione
religione = alleata del capitalismo
dunque religione = parte del problema
Un due più due apparentemente banale, ma anche un evento storico che apre a domande.
Il materialismo storico nasce così come reazione: un tentativo di riportare l’uomo alla concretezza della sua condizione reale, di smascherare l’idealismo come anestetico sociale, di recidere il legame tra sfruttamento economico e giustificazione spirituale.
In questo senso, il manifesto marxista funziona. Ha una sua coerenza interna. È una risposta logica a un sistema capitalistico feroce e disumanizzante.
Ma proprio qui emerge la prima grande anomalia.
La prima grande inversione: comunismo e materialismo
Il comunismo, come modello sociale, sembra richiedere un altissimo livello etico: fiducia, responsabilità, coscienza collettiva, superamento dell’egoismo individuale.
Eppure viene fondato su una visione materialista dell’essere umano, ridotto a prodotto dei rapporti economici. Una sicurezza controllata: "Ciò che fai è per la collettività ma tu sei solo ciò che fai."
Paradossalmente:
il materialismo è perfettamente coerente con il capitalismo;
il capitalismo si è storicamente alleato con la religione;
il comunismo è stato associato all’ateismo.
Un’inversione così evidente da apparire quasi artificiale. Uno schema distante da una sua possibile evoluzione naturale.
Se il capitalismo mercifica tutto, perché si appoggia al trascendente?
Se il comunismo aspira all’uguaglianza e alla cooperazione, perché priva l’individuo della sua dimensione spirituale?
Questa contraddizione non invalida Marx come pensatore, ma suggerisce che egli abbia reagito a un quadro già distorto, accettandone implicitamente una delle premesse fondamentali: l’identificazione della spiritualità con la religione istituzionale e, quindi, con il potere economico.
In altre parole, se la religione era già stata contaminata, rifiutarla in blocco significava forse gettare via anche ciò che di autenticamente spirituale conteneva. Oggi a molti pensatori potrebbe apparire un'elaborazione ingenua. Ma forse era voluta?
Comunismo come reazione, non come evoluzione
Qui si apre una possibilità interpretativa più ampia.
E se il comunismo non fosse nato come naturale evoluzione del pensiero umano, ma come reazione a un contesto estremo, dunque inevitabilmente polarizzata?
Una reazione:
nasce sempre in opposizione;
porta il segno di ciò che combatte;
tende a semplificare, irrigidire, escludere.
Il comunismo storico nasce contro il capitalismo, non oltre il capitalismo. Nasce come risposta urgente, non come sintesi matura. Infatti viene dissociato dai veri valori etici e spirituali del modello stesso. Un errore?
Una reazione può anche essere indotta. Col senno di poi possiamo divertirci a ipotizzarne i fattori scatenanti. Preparare un terreno di ingiustizia, sfruttamento e alleanze perverse può rendere inevitabile una risposta radicale e incompleta. Un disegno?
Non è necessario evocare complotti nel senso ingenuo del termine. Basta osservare che la storia procede spesso per polarizzazioni guidate, in cui le alternative offerte sono semplici reazioni. Negli ultimi decenni ne abbiamo visto molti esempi: Torri Gemelle -> Attacco all'Afghanistan.
Un modello avanzato, scorporato dalla sua anima?
Da decenni esistono narrazioni, ipotesi alternative, messaggi canalizzati — non dimostrabili, ma esistenti — che descrivono civiltà "extra" non competitive, cooperative, prive di proprietà privata, fondate su ruoli naturali e talenti individuali. Ci vengono mostrate come civiltà molto avanzate spiritualmente.
Modelli che, nella forma, ricordano sorprendentemente ciò che noi abbiamo chiamato comunismo.
Con una differenza enorme: in queste descrizioni l’individuo non è annullato, ma esaltato.
Rimanendo nel campo delle ipotesi, si potrebbe pensare che:
un modello molto avanzato sia stato mostrato all’umanità;
ma deliberatamente scorporato dalla sua radice spirituale;
così da renderlo fallimentare e rifiutabile.
Il risultato sarebbe duplice:
il concetto entra nella coscienza collettiva;
ma viene associato a oppressione, controllo e infelicità.
Il seme resta, ma viene respinto. A quale scopo?
Capitalismo, religione e la frattura finale
Nel frattempo, il capitalismo — espressione massima del materialismo — si è consolidato proprio grazie all’appoggio di sistemi religiosi istituzionali.
Come se spiritualità e materia, etica e potere, individuo e collettivo fossero state deliberatamente separate e distribuite in campi opposti. Come è già stato detto, è talmente paradossale che sono legittimato quanto meno a sospettarlo.
La questione non è cosa credere, ma cosa integrare
Questa riflessione non pretende di dimostrare nulla. Propone una lettura possibile.
Che tutto ciò sia stato il frutto di un piano, di dinamiche storiche immature o di una combinazione delle due cose, il punto resta:
Oggi conosciamo il modello.
Ne abbiamo visto il fallimento parziale.
Forse ora siamo chiamati a riflettere liberamente?
Potrebbe essere l'induzione di una Scelta?
Forse il comunismo non era da accettare così com’era. Ma forse non era nemmeno da scartare del tutto.
Forse il vero passo evolutivo non è aderire a un’ideologia, ma ricomporre ciò che forse è stato volutamente separato per garantirci il libero arbitrio di scegliere:
cooperazione e spiritualità,
individuo e collettivo,
libertà e responsabilità.
Forse spetta a noi, oggi, il compito di rimettere insieme i modelli con i loro rispettivi valori etici e spirituali. Forse è una chiamata per indurci liberamente a un'evoluzione: se il comunismo fosse stato perfetto, oggi vivremo perfettamente ma senza saperlo perché non lo avremmo scelto. Ecco che prende senso la possibilità, per quanto assurda, che sia tutto un disegno. Se guardiamo al risultato non è più importante sapere se effettivamente sia stato un disegno voluto o un caso assurdo. Abbiamo una confusione da riordinare e ne trarremmo evoluzione.
Il resto — nomi, sistemi, bandiere — potrebbe essere solo superficie.
Tutto ciò sono solo Ipotesi che affiorano unendo puntini che esistono già. A ciascuno la propria scelta.
Nel mio saggio GENESI INVERSA ipotizzo che potremmo essere guidati nella nostra evoluzione da intelligenze (Nephilim) che, dai tempi dei Sumeri, ci spingono a Scelte attraverso la creazione di dinamiche in opposizione.
Davide Ragozzini per Maestro Silenzio Edizioni